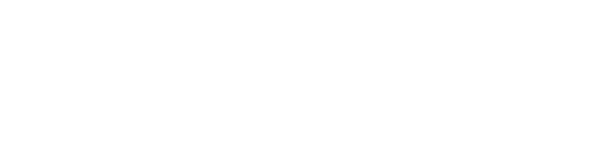Almeno una volta nella vita chiunque si sarà posto questa domanda: a cosa serve studiare i classici? Perché tediare i ragazzi con ore di lingua e letteratura in materie morte e sepolte, che parlano di autori morti e sepolti? Quesiti legittimi, cui ognuno dà la propria risposta, e sebbene non si pretenda, certo, di cambiare l’opinione di nessuno, le parole del prof. Camillo Neri, ordinario di Letteratura greca all’Alma Mater e nostro ospite, fanno riflettere e ripensare il nostro rapporto con il passato: i classici, tantopiù gli antichi, non solo sono ancora tra noi, ma difficilmente potremo “evitare” di tramandarli finché saranno in grado di essere attuali.
Il primo strumento con la quale un’opera viene trasmessa e interpretata è la traduzione, cioè quello sforzo considerevole di comprendere il messaggio di un testo, cosicché non si perda nel passaggio da una lingua a un’altra. La vera sfida di ogni traduttore, infatti, non sta tanto nel rispettare le strutture formali e grammaticali di un testo; cosa certamente molto importante se tradurre, come il professore ci insegna, “richiede concentrazione e quotidiano allenamento”. Ma un testo deve essere capacesoprattutto di rivivere “inalterato” nella lingua di arrivo e questo, con buona pace dell’allenamento, richiede propriamente un “miracolo”, una profonda ispirazione e capacità introspettiva.
Tutte le lingue, dal mitico episodio della Torre di Babele in poi (Genesi 11, 1-9), sono differenziate, e non tutti i messaggi sono esprimibili con la medesima intensità. Ogni lingua, ad esempio, sviluppa un lessico che è proporzionato alla sue specifiche esigenze espressive (molto concrete, legate alla vita di tutti i giorni, prima che letterarie) e lo arricchirà o impoverirà di conseguenza. Il greco, ad esempio,lingua filosofica per eccellenza, presenta almeno otto parole per esprimere diverse idee di amore. Due di queste, “agàpe” (amore come dono) e “philia” (amore come affetto amicale), ritornano, come faceva notare il professore, in uno degli episodi conclusivi del Vangelo secondo Giovanni in cui Gesù chiede per tre volte a Pietro se lo amasse. Ebbene, la traduzione italiana (prima della revisione CEI del 2008) tendeva ad appiattire tutto sotto il segno della parola “amore”, perdendo con ciò la profondità del testo greco: Cristo, che chiede a Pietro un amore di “agàpe”, e dunque un amore puro e di dono assoluto, sente Pietro rispondergli con amore di “philia”, cioè incapace di porsi sul medesimo piano divino. Al di là del messaggio evangelico, emergono con forza quelli che il filosofo spagnolo Ortega y Gasset definiva “i silenzi del testo”, cioè quella componente di inesprimibilità della lingua di un autore, nel suo stadio originale, che il traduttore deve cercare, come sua missione, di colmare e rievocare. In fondo, non è proprio l’oscurità di un testo (chiaramente provocatoria, come la Commedia di Dante) a rendere quest’ultimo affascinante e vitale?.
Tra originale e traduzione, conservazione e adattamento un principio rimane comunque inalterabile: i veri Classici (con la “c” maiuscola) trasmettono l’universale, una certa visione del mondo che può sempre fruttificare, al di là di confini temporali e geografici. Se, come scriveva un grande latinista come Alfonso Traina, “i classici parlano per noi”, forse sarebbe bene, come ha suggerito il relatore, che “quel noi diventi un tutti, in cui i libri vivono in comune tra generazioni diverse e per questo sempre in contatto”. Ciò conduce all’ultima lezione: si sente dire spesso che latino e greco educano al ragionamento e al pensiero logico. Verissimo, ma solo se prima impariamo che le lingue classiche e la loro traduzione sono in realtà l’emblema del dialogo verso l’altro, il diverso. Per dirla con il prof. Neri, “la traduzione è il vincolo tra ciò che ci allontana e ci unisce: è la sfida dello straniero”. Che imparare a tradurre possa insegnarci ad essere più umani?