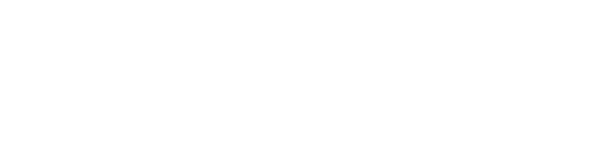Fino a non molti anni fa chi fosse afflitto da trisomia 21, volgarmente conosciuta come sindrome di Down dal nome del suo scopritore, poteva ambire a una speranza di vita non superiore ai nove/dodici anni. Oggi, invece, si attesta intorno ai settant’anni, in larga parte grazie ai grandi passi della scienza medica e all’impulso di uno straordinario ricercatore che negli anni ’50 del Novecento ha dedotto e dimostrato le origini genetiche di questa sindrome: Jerome Lejeune. Pierluigi Strippoli, ricercatore e professore di genetica nella nostra Alma Mater, è venuto a raccontarci la vita e il genio di Lejeune, in una storia che segue parallelamente vicende personali, una grande eredità scientifica e gli ultimi fronti della ricerca sulla trisomia 21.
Lejeune era un giovane dottorando in carriera quando nel corso dei suoi studi in ambito pediatrico si imbatte nella sindrome di Down. Dai tempi della sua identificazione a fine Ottocento sulla base di alcune evidenti similarità somatiche, vennero proposte le tesi più disparate sulle cause della trisomia 21 nei neonati: generalmente venivano legate a presunte “sporcizie morali” o “impurità” da parte dei genitori, con tutte le distruttive conseguenze sociali per il nucleo familiare che ben ci si può immaginare. Lejeune, invece, quando ancora la genetica era una scienza pionieristica, ne individuò, come detto, le reali origini e iniziò una personale battaglia di ricerca che, da un lato, condusse lui stesso alle soglie del Nobel, dall’altro migliaia di bambini (oggi adulti) a una vita pressoché normale, libera dai falsi pregiudizi che ne intossicavano la vita.
Tuttalpiù, come ha sottolineato Strippoli, Lejeune riuscì ad intuire almeno due grandi verità sulla trisomia 21, una certamente metodica e razionale, l’altra meno categorizzabile ma ugualmente percepibile. Innanzitutto, che la natura della sindrome è principalmente metabolica, consentendo un intervento più mirato e meno invasivo sul paziente e aprendo nuove strade alla ricerca; in secondo luogo, Lejeune fu il primo a parlare apertamente di “gene della felicità” in relazione alla sindrome. Non è un controsenso rispetto ad alcuni esiti potenzialmente devastanti sulle capacità intellettive, quanto piuttosto una notazione sul clima di affettività che le persone affette da questa sindrome riescono a creare intorno a sé. “E’ una naturale capacità di socializzazione”, ha ripetuto Strippoli, “forse la tendenza a compensare con una spiccata emotività e relazionalità le maggiori difficoltà nell’apprendimento”.
Ad oggi la ricerca sulla trisomia 21 ha fatto passi da gigante e i futuri interventi, che potrebbero lenire la sindrome già nel grembo materno, sono in fase di sviluppo e in attesa di approvazione e finanziamento. In questo senso, hanno avuto un ruolo di primo piano anche la nostra università di Bologna e l’equipe del prof. Strippoli, mediante un finissimo progetto di ricerca sul gene sovrannumerario. E’ opportuno ricordare che la trisomia prende il nome proprio dalla presenza di un gene in più rispetto alla norma nella ventunesima coppia di cromosomi; dunque se in questo cromosoma si scova una sezione comune a tutti gli affetti dalla sindrome, è lì che probabilmente risiederà la chiave di volta. Ancora più entusiasmante che ha portare avanti le ricerche sia stato un gruppo di giovani ricercatori, animati da conoscenza, grandi valori, nonché spirito di sacrificio.
Insomma, la ricerca dimostra ancora una volta di essere l’unica vera arma a nostra disposizione; insieme a una buona dose di amore e affetto che, rendendo tutti un po’ più accettati, rende tutti anche un po’ più umani. Questo soprattutto, per concludere con Lejeune, se “la medicina è l’arte di odiare la malattia e amare il paziente”, senza distinzione.